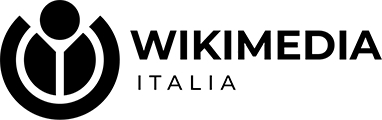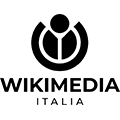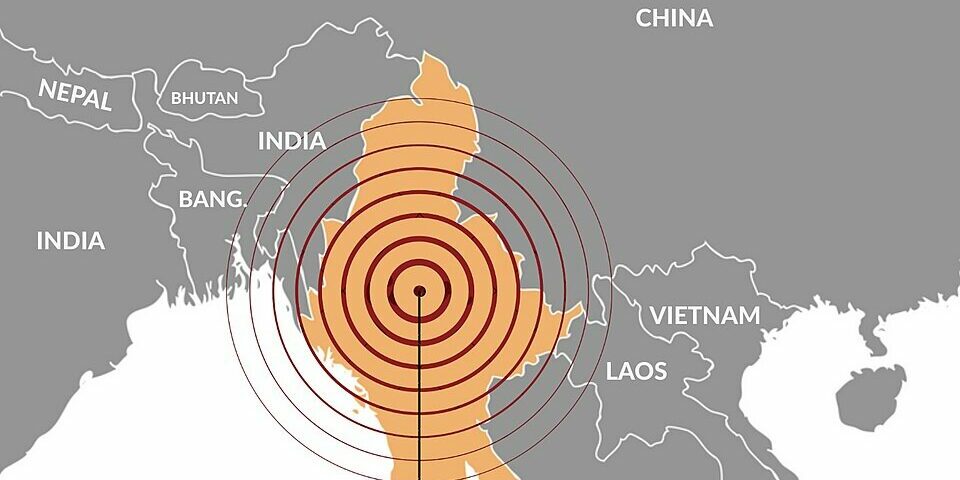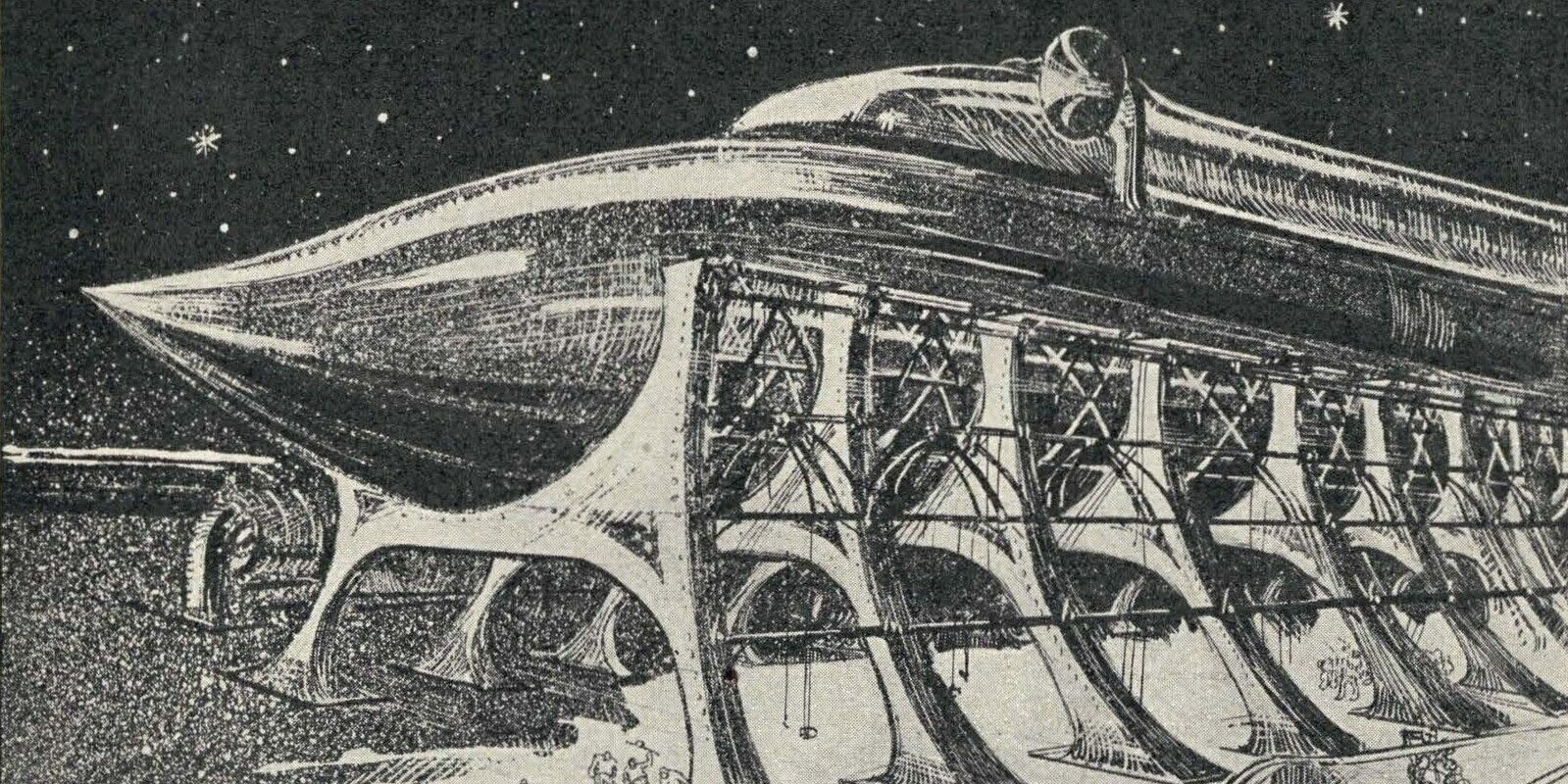Obiettivo 10: Ridurre le disuguaglianze

Negazionismo dell’Olocausto: gli Eichmann di carta
14 Gennaio 2021
Un’anteprima sui lavori del bando “wiki teatro libero”
14 Gennaio 2021Si è concluso da poco questo particolare 2020 nel quale, in una retrospettiva economica, ci sono stati due enormi flussi monetari: quello formato degli aiuti politico-istituzionali (come Cassa Integrazione, FIS, etc.) e quello relativo alla cosiddetta “Economia da Lockdown”. Parliamo nel secondo caso di tutte quelle aziende che sono state coinvolte nella ricerca del vaccino, quelle che hanno permesso gli acquisti on line, i fornitori di servizi di logistica ed i grandi colossi informatici. Quest’ultimo gruppo in particolare è costituito da aziende che già avevano ruoli importanti nella vita dell’uomo occidentale e che grazie alla pandemia sono diventate ancora più centrali. Non diciamo niente di nuovo, ma è interessante vedere che questi due flussi si sono mossi opposto: se da una parte gli aiuti governativi, si sono mossi per diminuire e prevenire le disuguaglianze economiche, dall’altra una fetta considerevole della spesa ha foraggiato l’aumento di potere di determinate aziende facendo aumentare il patrimonio del cosiddetto 1% della popolazione e diminuendo quello della restante.
La pandemia ha messo in luce un’altra frattura sul piano sociale che però ha radici più vecchie e che non è imputabile alla pandemia: quella del digital divide. Possiamo dire che molte persone hanno fatto di necessità virtù: nel senso che anche chi in precedenza non ha voluto o non ha potuto immergersi nella “sfera digitale”, quest’anno ha dovuto mettersi in gioco o quantomeno ha dovuto provarci. Alcuni settori professionali hanno dovuto ricalibrare tutte le loro pratiche come quello dei medici di famiglia che ha subito una forte accelerazione sulla digitalizzazione o quello della scuola in cui molti insegnanti hanno dovuto confrontarsi con la didattica a distanza. Questi primi impatti sono spesso stati non semplici e complicati non solo dalla prospettiva dei “fornitori” (seguendo gli esempi sopra citati i medici e gli insegnanti) ma anche da quella degli utenti finali (pazienti ed alunni).
Ma non potevamo aspettarci altro, perchè di fatto in Italia, non ci sono mai stati dei piani nazionali che prendessero seriamente in considerazione di educare alla cultura del digitale ed ai media. Basti pensare alla Direttiva del Ministro del 15 marzo 2007 riguardante le linee di indirizzo e le indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, vietava a qualsiasi livello l’utilizzo dei dispositivi personali degli alunni. Si potrebbe argomentare a favore di questa direttiva che i telefoni del 2007 erano prevalentemente usati per telefonare ed inviare sms ma (anche se ai tempi vi era una discreta diffusione dei palmari e che l’uscita sul mercato dei primi iphone e senza tenere conto che questa legge teneva fuori dalle aule anche i personal computer). Ma la gravità della decisione non stava tanto nella anacronisticità, quanto piuttosto nella scelta di non voler curarsi di cosa fossero i dispositivi elettronici e se questi potessero essere utili per la scuola, di fatto è stato detto: l’insegnante non può controllare cosa fanno gli studenti sui loro dispositivi quindi questi dispositivi li teniamo fuori dall’aula. Questa direttiva è stata valida fino al 2016 quando vi fu un’apertura grazie al Piano Nazionale della Scuola Digitale in cui veniva contemplata la pratica del BYOD (Bring Your Own Device, porta il tuo dispositivo). Segnale d’apertura lodevole ma con una grossa pecca: si delega alla famiglia la possibilità di avere un dispositivo ed il tipo di dispositivo, creando disuguaglianza all’interno del gruppo classe nella quale si riflette inevitabilmente la disponibilità economica della famiglia stessa. Un’altra iniziativa lodevole nel principio ma di cui la realizzazione resta (molto) discutibile, sono i recenti “kit di digitalizzazione” con il quale si vuole contribuire a ridurre il digital divide. Lodevole perché si prova a far fronte ad un problema andando ad intercettare chi può avere delle difficoltà economiche, discutibile perché non è dando uno smartphone in comodato d’uso per un anno ad un membro per nucleo familiare con l’abbonamento a due giornali on-line che si risolve il problema.
Anche quest’anno nel rapporto DESI 2020 (Digital Economy and Society Index), l’Italia resta al di sotto della media UE collocandosi al 25 posto su 28 stati: solo il 42% degli italiani tra i 16 ed i 64 possiede le competenze base contro il 58% della media UE. La ricetta per fare in modo che il digital divide in Italia sia solo un ricordo non è fuori dalla nostra portata: bisogna investire in risorse che creino valore nel lungo termine e che facciano in modo che chi si trova in uno stato di minorità possa emanciparsi. E questa possibilità passa solo dall’Educazione. Gli strumenti che vengono forniti sono sì necessari ma da soli questi non sono in grado di assolvere il loro compito. L‘accesso ad internet deve essere un diritto applicato perché anche da esso passa la possibilità di poter migliorare la propria condizione sociale, di accesso al mercato del lavoro e di poter partecipare alla sfera pubblica. L’augurio per questo nuovo anno é che il fondo europeo NextGenerationEU sia realmente utilizzato come trampolino di lancio per un’ Europa e (sopratutto) un’ Italia più digitale. Che magari abbia anche il coraggio di investire nel software libero anche per evitare di aumentare l’infinito divario sociale che si è creato tra i vari CEO della Silicon Valley (1%) e i loro fruitori di servizi (99%).
Edoardo Tallarico
Nell’immagine: .United Nations, Public domain, via Wikimedia Commons