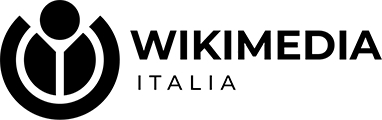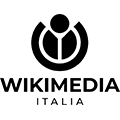Aspetti costituzionali della riproduzione fotografica di beni culturali
itWikiCon: per conoscere Wikipedia e il suo ecosistema
1 Novembre 2020
Teatri aperti con il bando di Wikimedia Italia
17 Novembre 2020Scriviamo spesso di libertà di panorama, un argomento ricorrente di queste pagine da quando abbiamo cominciato a occuparci dei numerosi problemi posti dalla normativa italiana a Wiki Loves Monuments e in generale alla diffusione della conoscenza sul patrimonio culturale in Italia. Oggi riprendiamo alcune riflessioni del professore Daniele Manacorda, che offre un punto di vista alternativo.
Abbiamo anche pubblicato un’intervista di Marco Maiocco al professor Manacorda sul medesimo tema.
Innanzitutto Manacorda inquadra l’importanza della questione delle riproduzioni, tutt’altro che secondaria nella generale politica di gestione dei beni culturali in Italia:
In questo elenco di follie che l’occhiuta gestione del “mercato delle riproduzioni” comporterebbe occupa un posto del tutto particolare la questione della libertà di panorama, ovvero del diritto di fotografare e riprodurre opere esposte al pubblico dominio. Più che surreale, marziana (nel senso di priva dei caratteri propri della specie homo sapiens), è l’idea che la libertà di panorama possa essere negata per manufatti storici, non importa di quale qualità, risalenti a secoli e secoli addietro, oggetto magari per generazioni delle più raffinate raffigurazioni da parte di artisti, viandanti, pellegrini e turisti e oggi preclusi alla pubblica documentazione in nome del combinato disposto di tre articoli-mostro del Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, altrimenti detto Codice Urbani.
Manacorda si rifà quindi alla migliore accademia, come gli scritti del professor Giorgio Resta:
Resta 2013 cita in proposito un limpido pensiero di A. Rouast risalente al lontano 1919: «Un paesaggio appartiene a tutti; ognuno può non soltanto contemplarlo liberamente, ma anche disegnarlo, fotografarlo e riprodurre il proprio disegno o negativo». Oggi – commenta Resta – assistiamo invece ad «una crescente espansione delle prerogative dominicali a detrimento della libertà di informazione e di iniziativa economica dei terzi».
No, non è attraverso cavilli giuridici capziosi che sarà possibile arginare la libera riproduzione dei beni esposti al pubblico dominio senza coartare la libera espressione del pensiero.
Basterebbe rifarsi alle più sensate prese di posizione del Governo Prodi, che nel lontano 2008 aveva considerato lecito fotografare per qualunque scopo anche commerciale i beni esposti alla pubblica vista distinguendo «tra beni culturali visibili esternamente dal quivis de populo e beni culturali collocati, invece, all’interno dei monumenti»
Purtroppo anche queste interpretazioni hanno incontrato delle resistenze da parte di persone che adducono ragioni economiche, che però sono gravide di conseguenze:
Come lascio valutare quale ideologia si celi, magari inavvertitamente, dietro a queste posizioni [contrarie alla libertà di panorama]: dove si decide se un introito valga più o meno di una libera manifestazione del pensiero? chi decide, in altre parole, quale sia il “bene degli altri”? se è già problematico attribuire in toto alla politica, attraverso le istituzioni pubbliche, un simile delicatissimo compito, quanto improprio sarebbe affidarlo alle pratiche della Pubblica Amministrazione! Il guaio è che attorno a questa sindrome del balzello (che dovrebbe paradossalmente ridurre la pressione fiscale!) [chi sostiene l’attuale regime] costruisce un castello di organi e procedure ispirato ad una pervasiva cultura del controllo, che – sia detto per inciso – la Pubblica Amministrazione dovrebbe proficuamente esercitare in molti campi delle attività economiche e sociali, ma che sarebbe altamente raccomandabile tenere lontana dal comparto culturale. Un occhiuto Grande Fratello dovrebbe dunque garantire la collettività che essa stessa non si stia attribuendo la libertà di usare del proprio patrimonio culturale. Un esercito di controllori dovrebbe gestire una mastodontica operazione di spionaggio pubblico pronti a carpire scatti indebiti e, peggio ancora, usi indebiti di ciò che è di tutti. Dov’è lo scandalo? la domanda giusta da porsi sembra a me infatti tutt’altra: chi e che cosa vieterebbe l’uso del patrimonio culturale a fini di promozione commerciale? e ancora: perché dovremmo vietarlo? Se la risposta è per “la dignità del patrimonio”, ne accennerò in seguito (cfr. infra); se non è questione di dignità, ma di tutela di un presunto monopolio in capo al proprietario del bene materiale anche del valore immateriale ad esso associato, almeno non usiamo argomenti ideologici (dignità e quant’altro) e diciamo, pane al pane e vino al vino, che vogliamo uno stato “bottegaio”, che si misura nell’arengo economico su di un piano di pura concorrenza commerciale di basso profilo, che non vede gli altri aspetti costituzionali del tema, e risolve la questione nei termini di quella gestione diretta monopolistica […].
Quindi ben venga la libera utilizzazione da parte di privati, imprese, associazioni con o senza scopo di lucro di ogni sorta di immagine liberamente tratta dal nostro patrimonio culturale, per il quale quei segni costituiranno un possibile volano pubblicitario di ulteriore diffusione di conoscenza e quindi di apprezzamento del brand Italia. E ben venga naturalmente che anche singole istituzioni culturali si dotino di marchi registrati […]: una opportunità concessa loro dal Codice della proprietà industriale, che è legittimo domandarsi quanto possa essere interpretata quale una riserva esclusiva di utilizzo della fonte ispiratrice del segno.
Secondo Manacorda, una chiave fondamentale per risolvere la questione è ricordarsi della differenza fra beni rivali e ben non rivali:
Come si esce da questo garbuglio? Sembra abbastanza evidente che il problema principale sia posto proprio da quegli articoli del Codice che normano le concessioni. Abbiamo visto la incoerenza dell’art. 108. […] Beni materiali e beni immateriali sono quindi programmaticamente mescolati e confusi […]. Le riproduzioni di immagini attengono infatti alla concessione d’uso di un bene immateriale, mentre le riprese televisive comportano comunque anche l’uso degli spazi […] usi, che in un caso (quello delle concessioni d’uso degli spazi così come dei beni materiali del patrimonio) sono indubbiamente rivali, mentre per quanto riguarda le riproduzioni di immagini sono palesemente non rivali (Maurizio Franzini 2011). In altri termini, mentre cedendo l’uso di uno spazio o di altro bene pertinente a un istituto o a un luogo della cultura, se ne impedisce contestualmente il godimento da parte di altri possibili fruitori, e ciò giustifica il titolo oneroso della concessione; nel caso delle riproduzioni di immagini, l’uso da parte di un singolo, di un ente, di una impresa, di una comunità non ne impedisce in alcun modo il godimento contestuale da parte di altri, dal momento che il bene è posto, nella sua immaterialità, a disposizione di tutti.
La distinzione concettuale e operativa tra usi rivali e non rivali dei beni culturali di proprietà pubblica potrebbe quindi portare un po’ di luce e di sereno in un campo dove l’economia della bottega prevale sulla considerazione più generale del bene pubblico in presenza di beni comuni immateriali. In altri termini, la condizione di non rivalità riconosciuta ai beni immateriali rappresentati dalle immagini del patrimonio culturale pubblico li esclude di fatto dal mercato, mentre è giusto che siano sottoposti al mercato quei beni il cui uso rivale li assimila di fatto a beni privati, ma di proprietà e di gestione pubblica. La liberalizzazione generale e completa dell’uso anche commerciale delle immagini darebbe loro lo statuto di beni pubblici non escludibili, sottratti al mercato, e quindi anche all’uso improprio che potrebbe esserne fatto dai giganti della comunicazione globalizzata. E restituirebbe alla capacità delle comunità di produrre innovazione, informazione e cultura attraverso di essi, con generale giovamento del livello della produzione e diffusione culturale, da un lato, e della creazione di lavoro e ricchezza con le relative ricadute positive di carattere fiscale sulla finanza pubblica.
Si inserisce qui un aspetto, quello della dignità del patrimonio, che non possiamo approfondire in questa sede, ma che tende a confondersi con “la destinazione culturale del bene”, prevista dall’art. 106, comma 1 del Codice Urbani, oggetto di ampia discrezionalità. È evidente che il testo di legge fa riferimento a usi materiali dei beni, di carattere degradante o tali da «recare pregiudizio alla loro conservazione», e certamente non all’uso della loro componente immateriale. La tutela del decoro, «un concetto giuridico indeterminato» (Casini 2018), è un tema assai scivoloso. E ancor più foriero di ambiguità quando utilizzato «nella esigenza di assicurare una forma di “controllo” sull’originalità, sulla autenticità e sulla “veridicità” delle cose che costituiscono il patrimonio culturale» (ibidem). Basti fare un veloce riferimento al dibattito sullo statuto della copia e del falso, per rendersi conto che, almeno in questo campo, lo Stato potrebbe accontentarsi di garantire l’autenticità dei beni in sua proprietà, senza doversi accollare anche la ben più ardua fatica di “produrre certezza”.
Infine, Manacorda ribadisce i rischi per beni costituzionali superiori quali la libertà di espressione (art. 21) e insegnamento (art. 33) e la promozione della cultura (art. 9), se dovessero essere limitati da meri provvedimenti amministrativi del ministero:
[In Italia] non mancano le prese di posizione che giustificano le restrizioni alla libertà di espressione in nome di un presunto diritto (di chi? in base a quali principi?) ad evitare la “banalizzazione” del patrimonio culturale per assicurarne “un uso corretto”. Ma chi giudica se l’uso di una immagine sia o non sia consono? La politica, come in uno stato etico autoritario? L’amministrazione, come in uno stato tecnocraticamente occhiuto? La magistratura, in nome di un “comune senso del pudore” (Art. 527 Codice Penale)? Sperabilmente né l’una né l’altra né l’altra ancora […] oltre un secolo fa l’amministrazione statale della tutela ha ideato e diretto lo smantellamento del barocco da tutte le chiese del Regno perché quello stile non era “degno” e che Gian Lorenzo Bernini voleva demolire il mausoleo di Cecilia Metella per trarre almeno le pietre da quella vecchia rovina non “degna” di stare in piedi? Quando nel 1919 Marcel Duchamp mise i baffi con tanto di volgare didascalia alla Gioconda (no: all’immagine della Gioconda!) [chi difende il codice dei beni culturali] l’avrebbe forse deferito ai tribunali della Francia repubblicana? “Ma quella è un’opera d’arte!”. Già. E chi decide che cosa sia o non sia, oggi – e domani chissà? – un’opera d’arte? quale Agenzia, ente terzo o organo interno, si assumerà, e su quali basi giuridiche, questo immenso ingrato compito?
Mi limito solo a registrare quanto attuale sia un radicale ripensamento del ruolo della gestione pubblica in questo campo, che – assegnato dalla Costituzione alla Repubblica e non allo Stato – nella formulazione del Codice Urbani ha posto in capo addirittura al solo Ministero dei Beni Culturali alcune prerogative di esclusività, che vanno ben al di là del campo della tutela per occupare, nella prassi, anche quelli della valorizzazione e della gestione e, nella lettera dell’articolato, addirittura quello della ricerca, con risvolti di palese incostituzionalità che più prima che poi andranno pur risolti.
Nell’Immagine: Torre di Satriano, foto in concorso Wiki Loves Monuments 2019 di Michele Luongo, licenza CC BY SA, via Wikimedia Commons